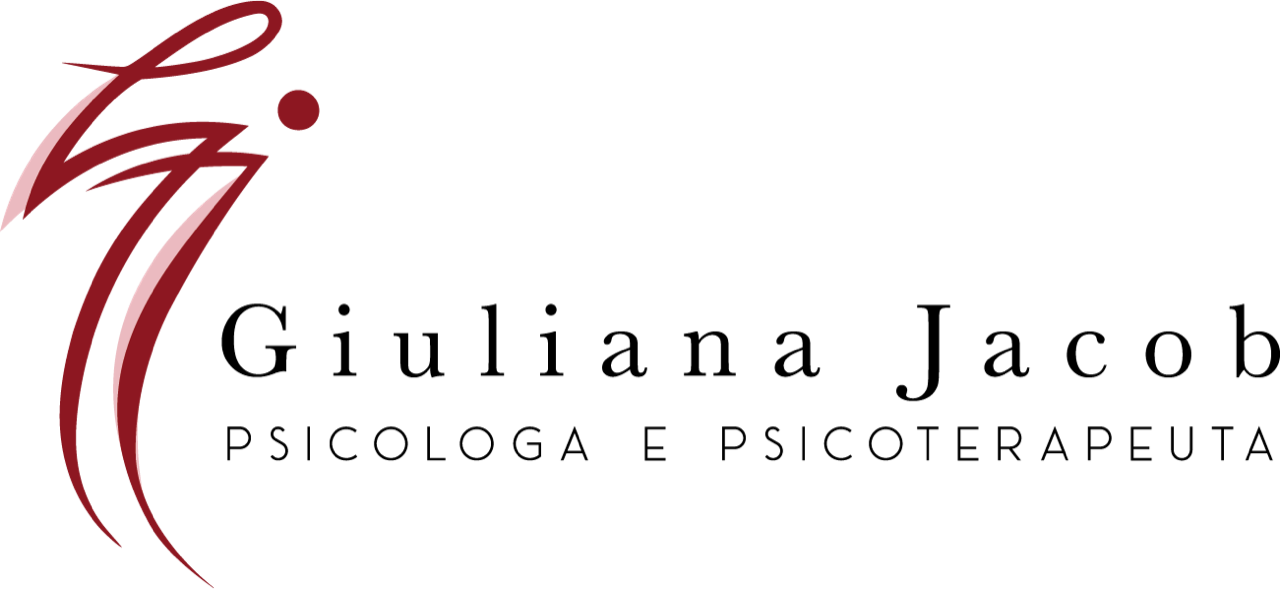Vittima? no, sopravvissuta
Noi sappiamo che ciò che viene detto esiste proprio nel modo in cui viene detto.
Inizialmente è stato importante nominare le donne come vittime di violenza per affermare con chiarezza che erano loro a subire le aggressioni maschili e anche per rompere con un’interpretazione che le voleva provocatrici e corresponsabili. Tuttavia, è diventato presto evidente che così si rischiava di rafforzare un altro stereotipo e cioè che le donne maltrattate fossero passive o addirittura trovassero soddisfazione nella violenza che veniva loro inflitta. (vedi Romito, 2000).
La “vittima” perde la sua individualità, viene fissata in una posizione di inferiorità, diventa suo malgrado oggetto, con il rischio, che qualora non corrisponda più allo stereotipo della vittima “perfetta”, non sia più creduta, ascoltata, tutelata.
Oggi perciò si cercano altre parole. Nei Paesi di lingua anglosassone si parla di “sopravvissuta” per rendere conto dell’orrore attraversato e della capacità di resistenza. Nei casi meno devastanti, si potrebbe pensare a parole più neutre come “bersaglio” o a perifrasi, come “persona contro cui è rivolta la violenza”.